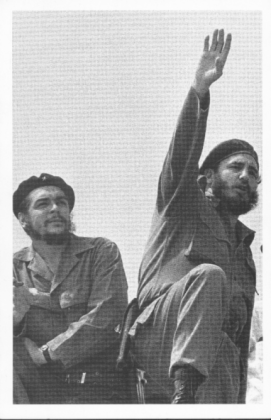

Ricordo Cuba
Ferruccio Braibanti
Venerdì 5 febbraio, ore 11,30, aeroporto della Malpensa: l’aereo fa ruggire i suoi motori; una lunga rincorsa, uno strappo violento e spicca il volo verso l’isola di Cuba, dall’altra parte dell’oceano Pacifico. Ci separano ancora più di ottomila km. Al nostro arrivo (ore 22,30 italiane, 16,30 cubane) saremo a Camagùey, città del centro isola, a 533 Km da La Habana. Ad attenderci all’aeroporto ci sarà un nostro compagno, che ci ha preceduto di due settimane, e da alcuni dirigenti cubani.
Il volo passa tranquillo: un qualche modesto sobbalzo, che comunque mi procura un po’ d’ansia e tanta voglia di ritoccare la terra. Finalmente l’aereo abbandona la quota di 11.700 metri a cui ha volato ad una velocità superiore agli 800 Km/h e rapidamente tocca il suolo cubano.
Sono le quattro del pomeriggio.
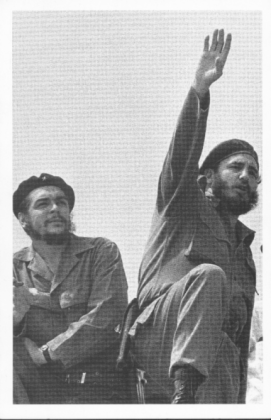

Dalle terrazze dell’aeroporto alcuni curiosi guardano l’aereo partorire i turisti. Scendo la scala dell’aereo sotto cui sta un poliziotto che mi guarda le scarpe.
Una cinquantina di passi e raggiungiamo la frontiera, dove una gentilissima, ma ferrea poliziotta mi controlla il passaporto, chiedendomi, in spagnolo, qualcosa che non capisco e a cui rispondo con ripetuti si. Doveva essere una frase di benvenuto perché il tutto si è concluso con un complice sorriso. Sorriso che ho colto come auspicio di un gradevole soggiorno, subito smentito dal fatto che le mie valige non erano arrivate.
Nell’atrio dell’aeroporto, assieme al nostro compagno, stavano il Responsabile delle relazioni esterne di Poder Polpular della Provincia di Camagùey e il direttore della Camera di Commercio. Nonostante le loro potenti raccomandazioni, che hanno smosso il personale cubano dalla abituale flemma caraibica, la mia valigia non si trova. Arriverà da Milano qualche ora dopo con un aereo di una compagnia diversa da quella che ci ha portato a Cuba.
Un taxi ci accompagna ai nostri alloggi: io ho scelto di vivere in una casa particular: nei dieci giorni di permanenza ho deciso di conoscere Cuba attraverso un rapporto molto diretto con la gente.
L’impatto con il territorio cubano è duro: sapevo che avrei conosciuto una realtà molto povera, ma la prima impressione supera la mia immaginazione. Nelle strade non c’è traffico. Molta gente a piedi, molta in bicicletta, su cui abitualmente stanno due o più persone. Qualche motocicletta col sidecar, molti carri trainati da cavalli in una versione miserrima delle carrozzelle che ancora accompagnano i turisti tra i monumenti di Roma e di Firenze. Lì i carri non accompagnano turisti, ma sono i normali mezzi di trasporto dei cubani. Troviamo qualche autocarro adibito ad autobus e qualche automobile, quelle grandi auto americane degli anni 50.
Arriviamo finalmente nella città di Camagùey: le guide la descrivono come un labirintico dedalo di stradine e come la città degli otri, grandi recipienti di terracotta che servivano sino a prima della rivoluzione per raccogliere l’acqua piovana per le esigenze idriche della popolazione.
I marciapiedi sono invasi di gente: tutta mal vestita, tutta lenta. Le strade sono piene di biciclette, anch’esse lente. Le case sembrano non ricordare nemmeno di essere state pitturate: sono grigie, decadenti, senza vetri alle finestre. Incomincio a pentirmi d’avere scelto una casa particular, che, leggo poi su una guida turistica, non è altro che una casa privata, che ha ottenuto il permesso di ospitare a pagamento i turisti. Un po’ come le pensioncine di un tempo in Liguria, in un contesto di povertà non dissimile da quello conosciuto dall’Italia prima della ricostruzione. E’ questa un’immagine che mi accompagnerà per tutto il periodo di soggiorno a Camagùey, un po’ mitigata da una maggiore conoscenza dei luoghi e delle persone. Un po’ mitigata perché ho potuto rendermi conto che c’è povertà, ma non miseria; che quello che apparentemente avevo giudicato come un modo povero di vestirsi è per i Cubani il modo di vestirsi. Siamo in un paese Caraibico, lontano dal gusto Europeo e dallo stylig italiano.
Noi italiani siamo riconosciuti a prima vista, nonostante indossiamo blu-jeans e camicia. Qualche signora non più giovanissima ci avvicina con un "que lindo": la qual cosa mi aveva anche un poco infastidito perché, non conoscendo lo spagnolo, credevo che lindo (suggestione della pubblicità televisiva italiana?) volesse dire pulito. Solo dopo diversi giorni ho capito che lindo vuol dire bello.


Per strada però non ti avvicinano solo anziane signore, ma anche ragazzi, che per far vedere che conoscono l’Italia ti snocciolano una serie di nomi di cantanti che, per ignoranza, io non conosco. Ma ti parlano anche di mafia e di nomi di mafiosi italo-americani, legati sicuramente alla storia cubana interrotta dalla rivoluzione. E ti fermano anche le cicas, ragazze giovani e dolcissime, dagli occhi neri, intelligenti e con la carnagione nera, bianca o caffè e latte.
Sono belle: ti agganciano e ti invitano. Sono spigliate, simpatiche, ridenti e ti danno l’impressione di una gioia di vivere che in Europa non è facile trovare. Qualcuna mi offre amore, ma non mi chiede soldi. Un’altra mi parla della moda italiana, trovandomi assolutamente impreparato, e mi fa capire che se le regalassi un maglioncino o una camicia sarebbe contenta. A una ragazza, di poco più di vent’anni, ho regalato un maglioncino che non avevo mai indossato e che avevo portato con me, quella sera, per ripararmi le spalle dalla leggera brezza che soffia sugli inverni cubani. Me lo aveva chiesto in prestito promettendomi che me lo avrebbe reso la sera successiva. E la sera successiva è venuta all’appuntamento, col maglioncino. Io avevo un impegno di lavoro, così non ho potuto andare a recuperarlo, per cui quel maglioncino le è rimasto, come ricordo d’un amico di cui forse non ricorda neppure il nome, come io non ricordo il suo.
Ho conosciuto un’altra ragazza: Baby, ma forse non è il suo vero nome. L’ho conosciuta alla Casa della Trova, nel centro antico di Camagùey. Era creola, bella, di vent’anni: simpatica, capace di tenere la conversazione con uno straniero che non capisce la sua lingua facendosi comprendere benissimo. Era allegra, piena di brio e capace di muoversi al ritmo della musica cubana come solo una cubana sa fare. I suoi vestiti richiamavano vagamente la moda Europea, segno che qualche turista passato prima di me le aveva lasciato un qualche regalino. E’ stata lei a chiamarmi mentre mi recavo ad ordinare una bottiglia di Ron e, come se mi conoscesse da sempre, mi ha seguito al tavolo dove ero seduto con le autorità cubane. Queste l’hanno accettata come se fosse una loro amica: in realtà non la conoscevano. L’assoluta mancanza di differenza tra le classi sociali l’ho verificata in quella occasione, come anche quando il Direttore della Camera di Commercio si è fermato a chiacchierare con un mendicante, che non ci chiedeva dollari per mangiare, ma per poter entrare in uno di quei negozi dove si fa spesa solo coi dollari e non coi pesos.
Baby ora appartiene ai ricordi: di lei conservo un inutile numero di telefono, che non userò mai, sia perché la differenza di fuso ci fa vivere in ore della giornata molto diverse, sia perché non saprei cosa dirle.
Un ragazzo di colore nero, vestito di stracci, ci ha raccontato un’improbabile bugia: a suo dire, suo padre era medico e lui studente di lingue in una scuola privata dove pagava mezzo dollaro all’anno. Si appoggiava ad una sgangherata bicicletta: la sua bugia esprimeva innegabilmente una voglia di affermazione sociale che il socialismo reale cubano probabilmente gli nega. Ma è forse l’unico esempio che ho incontrato nei miei undici giorni cubani. Per il resto, per le molte persone che ho trovato, posso dire che ho riscontrato una forte soddisfazione per il forte sistema di protezione sociale realizzato dal governo cubano. L’insoddisfazione sta nella condizione economica in cui è relegata la gente di Cuba soprattutto dall’embargo statunitense e dalle sanzioni economiche applicate dagli USA alle nazioni che mantengono rapporti commerciali con l’isola socialista.
La gente a Cuba non ha quello che vorrebbe. Ma credo che, invertendo la frase, potremmo ricavare un concetto universale: in tutto il mondo la gente vorrebbe quello che non ha, sia nei paesi governati dalla più aperta democrazia, sia nei paesi governati dai più ferrei regimi.
Quello che spicca all’occhio anche del più disattento o del più fazioso visitatore di Cuba è l’assoluta mancanza delle spinte che vengono dalle iniziative del privato: ma l’ottica di osservazione è quella di un europeo troppo abituato al luccichio dei neon delle vetrine e che fa fatica a prendere in considerazione altri modelli di socializzazione che prescindano dal consumismo.


Man mano che passavano i giorni, però, mi sono sempre più reso conto che la vita dei cubani non è grigia come mi era parsa allo sbarco dall’aereo.
E’ tinta di colori diversi da quelli che tingono la nostra: colori pastello, tenui, delicati che sanno però accendersi d’una vivacità incredibile in momenti fortemente socializzanti.
La musica è un momento fortissimo di aggregazione: il suo ritmo assume quasi un valore religioso, rituale e per un europeo più divenire ossessiva. Ma per il cubano scandisce il quotidiano, lo differenzia nella particolarità del momento e lo integra in un ambiente in cui sole e vento sono decisamente sovrani.
Sono lontani i ritmi scanditi dalle sirene delle fabbriche, dagli orologi marcatempo, dagli squilli dei cellulari, dalle campane delle torri. Le ore trascorrono senza caratterizzazioni: non c’è l’ora del pranzo o della cena, non c’è l’ora per alzarsi, né arriva mai l’ora per fare qualche cosa. Da noi c’è un ora per tutto: a Cuba no. Gli appuntamenti si fissano in un posto, non in un momento. E’ uno stile di vita imposto da una cultura atavica che certo non dipende dal socialismo imposto dopo la rivoluzione. Anzi, è uno stile di vita contraddittorio col modello socialista tutto pianificazione, tutto raziocinio. Ma i due modelli convivono bene, senza contraddizioni che incidano significativamente sulla vita della gente.
Santa Lucia è un piccolo borgo sull’oceano: s’affaccia su uno specchio d’acqua d’un azzurro cristallino cinto dalla barriera corallina contro cui si frangono i flutti del Pacifico. La sua spiaggia bianchissima e fine è punteggiata da piccole palme ai cui piedi si trovano tante noci di cocco. Raggiungiamo Santa Lucia con un piccolo pullman che ci accompagna in una campagna incolta e arsa per 120 km. Il cielo è continuamente solcato dal volo di avvoltoi e nei numerosi acquitrini che costeggiano la deserta strada vivono infiniti trampolieri bianchi e grigi dalle svariate dimensioni. In quegli acquitrini, mi dicono, vivono i caimani, ma per quanto osservi non riesco a vederne nemmeno uno. Nei campi si vede un qualche raro contadino. Sta tagliando l’erba con un arnese molto simile al macete. In centoventi chilometri incontriamo una ventina di auto: sui sentieri che fiancheggiano la carreggiata siamo spesso affiancati da uomini a cavallo. Come sono magri e stanchi i cavalli cubani.
All’orizzonte si scorge una qualche bassa collina. Ad una ragazza avevo chiesto se a Cuba esistono montagne alte. Lei mi aveva detto di si ed io, curioso, le chiesi quanto erano alte. "Fino alle nuvole" fu la sua risposta a cui aggiunse "quanto sono alte le nuvole?".
A Santa Lucia mangio la mia prima aragosta pescata nell’oceano. La mangio in una casa privata, che non è una casa particular, ma semplicemente la casa di coniugi che abusivamente ristorano i turisti. Ho mangiato bene: aragosta, pesce di mare e gli immancabili riso bianco scondito e banane fritte. La cervesa è la bevanda più offerta e dopo qualche giorno anche a me comincia a piacere, anche se non sono un estimatore della birra. Mi manca il buon caffè italiano: anche se a Cuba si produce un ottimo caffè, il caffè che si beve è poco più che acqua riscaldata.
Marco approfitta della giornata priva di impegni e fa un’immersione in uno splendido braccio di oceano che penetra l’isola. A venticinque metri di profondità l’acqua ha una temperatura di 26° e lì Marco trova degli enormi squali, che, mi ha raccontato, nonostante la sua confidenza con le profondità marine, lo hanno impressionato. Durante l’immersione ha visitato il relitto di una nave ed io l’ho un po’ invidiato.
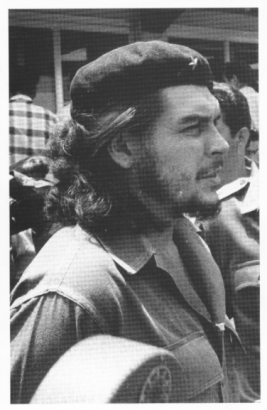
Il ritorno a Camagùey avviene con il buio. Non è un bel viaggio: troppo frequentemente ci dobbiamo fermare perché vi sono mucche sulla strada o perché la strada è attraversata da binari incustoditi. Nella campagna non brillano le luci come da noi. Il buio è attenuato solo dalla luce di una falce di luna. Anche l’autista non sembra a suo agio, nonostante sia un buon conoscitore del posto.
La visita agli ospedali di Camagùey mi ha profondamente colpito: io, che arrivo da un paese ricco, in cui il consumismo sanitario la fa da padrone, mi sono vergognato. A Cuba, senza soldi, senza tecnologie, senza medicinali i medici sono comunque stati in grado di raggiungere importantissimi risultati. La lebbra è stata totalmente debellata, la malaria è scomparsa, la presenza delle stesse malattie tropicali ha conosciuto un drastico ridimensionamento, la mortalità infantile è inferiore a quella italiana e l’aspettativa di vita di un cubano è uguale a quella di un europeo.
La mancanza di materie prime determina l’impossibilità di garantire nelle strutture sanitarie adeguati livelli igienici: pur tuttavia e pure a fronte di inadeguate protezioni antibiotiche le infezioni ospedaliere, che tanto preoccupano gli operatori sanitari italiani, non paiono essere un problema.
La mancanza del necessario ha obbligato le istituzioni sanitarie al ricorso alle medicine alternative: così negli ospedali e negli ambulatori pubblici troviamo agopunturisti, omeopati, iridologi, podologi ecc. Qualche cubano, non medico, ci decanta le virtù e l’efficacia di queste pratiche e ci invita a sottoporci ad un trattamento di agopuntura in un ambulatorio, da cui ci affrettiamo a scappare perché le norme della sterilizzazione ci sembrano piuttosto disattese.
Il personale medico, pur non nascondendoci le difficoltà in cui è costretto ad operare e pur invitandoci a far pervenire nelle strutture sanitarie materiale che negli ospedali italiani viene dismesso, ci mostra con orgoglio quello che fanno e come lo fanno, con l’ausilio di attrezzature fatiscenti, ma che comunque sembrano dare importanti risultati.
Nella visita all’ospedale pediatrico abbiamo potuto vedere neonati sottoposti a terapie intensive: un prematuro, dalla pelle nera e dal volto bellissimo, stava in una culla termica tenuta insieme con del nastro adesivo. Il mio sguardo preoccupato ha forse indotto il neonatologo a dirmi che la prognosi per quel bambino era ancora riservata, ma "ce la farà." L’ostentazione di sicurezza del medico ha reso un po’ meno triste la mia visita.
Sui muri dell’ospedale pediatrico stavano ossessivamente scritte le regole dell’allattamento al seno, gli effetti positivi sullo sviluppo del bambino, la sua assoluta insostituibilità con prodotti artificiali. Ho fotografato quelle scritte, che mi hanno riportato alla mente le parole di mio padre nella sua impegnativa lotta a favore dell’allattamento al seno contro le istituzioni ed i mercanti italiani. Ma mio padre mi è venuto in mente anche perché lui, come i medici Cubani, ha sempre fatto il medico, in ospedale e fuori, con poche attrezzature, ma con tanta scienza e coscienza ottenendo ottimi risultati e la gratitudine della gente.
Il 12 febbraio, di buona mattina, ci mettiamo in viaggio per La Habana. Prima tappa sarà Santa Clara, a circa trecento chilometri. Sono emozionato. Ci attende il mausoleo del CHE nella città che ha visto il trionfo della rivoluzione castrista.
Il gigantesco monumento del CHE ci appare all’improvviso. Sovrasta un’ampia area ed è bellissimo: una altissima stele sormontata dalla figura bronzea di Ernesto Guevara, che imbraccia il suo fucile. La guardo a lungo emozionato e commosso, mentre ripasso velocemente quelle poche nozioni di storia su quell’uomo che in maniera determinante ha contribuito alla riscossa dei cubani e alla loro liberazione dal giogo schiavista di Batista.
La visita alla tomba del CHE mi imbarazza: in una modesta cripta, tra i sui compagni rivoluzionari, stanno le martoriate ossa di un eroe invocato da centinaia di milioni di persone nel mondo, per le quali è divenuto il simbolo del riscatto della dignità umana.
Non so come esprimere quanto sento dentro: non so pregare e questo mi mette in una condizione di grande disagio perché sono lì, vicino al CHE e non riesco in alcun modo a parlargli. Resto in silenzio e penso: penso anche alla lettera che il CHE scrisse a Fidel Castro per dimettersi da comandante, da ministro e anche da Cubano in netto dissenso con la via che la rivoluzione castrista aveva imboccato e divergente dagli ideali rivoluzionari che avevano animato l’assalto alla caserma Moncada o lo sbarco del Gramma.
Quella lettera è scritta a grandi caratteri bronzei ai piedi della statua del CHE, testimonianza di un grande coraggio da parte di un regime che non ama il dissenso.
La visita è lunga e credo di poter dire che anche i miei compagni di viaggio ne sono stati turbati.
Il viaggio si conclude a La Habana, all’hotel Lincoll verso le otto di sera, dopo dieci ore d’auto.
L’Avana è molto diversa da Camagùey: è una grande città di tre milioni d’abitanti. E’ la capitale e lo si nota subito. Non vediamo la stessa povertà: auto nuove sostituiscono quasi tutti gli altri mezzi di trasporto che avevamo visto sino ad allora. Auto asiatiche, moderne che non sprigionano dai tubi di scappamento nuvole nere di fumo. Anche le biciclette non si vedono più, né i cavalli, né i sidecar. Anzi, qualche cavallo si, ma non è così magro e così stanco come a Camagùey.
La bodeguita del Medio, il Floridita, il Tropicana, la cattedrale, la fortezza, il faro, il mercato, il museo della Rivoluzione…. Tutto molto bello e interessante, ma abbiamo perso il calore umano di Camagùey, tutto assorbito dalla vita di una grande città. Dall’alto La Habana può sembrare una città devastata dai bombardamenti: in realtà è devastata dal tempo e dalla mancanza delle risorse per ristrutturala, anche se esistono quartieri eleganti, moderni, un po’ americaneggianti e palazzi sfarzosi, in cui sono ospitati grandi alberghi.
Tanti i grandi magazzini in cui si acquista solo in dollari: l’offerta di prodotti è a livello di grandi magazzini europei ed i prezzi anche. Ci si stupisce che siano pieni di cubani, che fanno acquisti spendendo cifre che il salario di sette dollari mensili, che mediamente percepiscono, richiederebbe anni per accumulare. Anche questa è una contraddizione del sistema: questi grandi magazzini sono gestiti dallo stato che offre prodotti ai cubani a prezzi improponibili per i cubani. Così i cubani che acquistano devono aver commesso illegalità, più o meno di rilievo. Perché, nonostante la propaganda, la criminalità esiste. Molto probabilmente non si tratta di criminalità organizzata, ma di micro criminalità, che comunque ti rende non troppo sicuro camminare per le vie di La Habana, nonostante la presenza di un poliziotto ad ogni angolo di strada.
E’ una sensazione di paura che ti accompagna per certe strade, un po’ forse ingigantita dalla difficoltà di accettare appieno la altrui diversità: col passare dei giorni e con una maggiore abitudine alla diversità il senso di paura diminuisce, ma non scompare del tutto. Tant’è che per uscire dall’albergo preferiamo utilizzare il taxi.
Il 16 mattina lasciamo L’Avana per Varadero, dove a mezzanotte ci imbarcheremo per l’Italia. Varadero è una bellissima città turistica che ha poco di cubano: lussuosissimi alberghi con un’offerta turistica di primissimo livello. Non mi piace, nonostante i bellissimi colori dell’oceano.
L’aereo parte con un’ora di ritardo: solleva le sue ruote dal suolo cubano alle 0,58 del 17 febbraio. Sbarcheremo a Milano dopo 10 ore (alle 16,45 , ora italiana) di un volo lunghissimo e monotono.
Sull’aereo i nuovi compagni di viaggio sono molto diversi da quelli che ci hanno fatto da cornice all’andata: fra i nuovi, molte cubane, che lasciano la loro terra per una nuova vita. E questo mi provoca sentimenti contrastanti: amarezza e fiducia.
Tornerò, Cuba.