

Associazioni
 |
melegnano.net |  |
Melegnano.net
Associazioni |
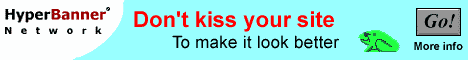 |
| I Longobardi
Non si era ancora spenta l'eco della guerra gotica che un numeroso 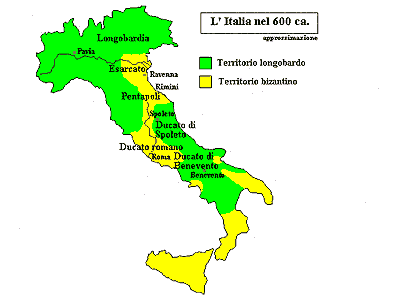 popolo nordico, guidato da re Alboino, si riversò sull'Italia nord-orientale.
I Longobardi erano una popolazione di stirpe
germanica affine per lingua, organizzazione politica, usi e costumi ai
Frisi, agli Angli ed ai Sassoni, il loro nome sembra derivi da lang
bart ossia popolo dalla lunga barba, oppure
da lang barte,
dalla lunga alabarda, vennero citati da Tacito come popolo ricco di coraggio
e valore guerriero. Insediati originariamente nel basso corso del fiume
Elba e poi migrati in Pannonia, l'odierna Ungheria occidentale e di lì
pure in Moravia, attuale repubblica Ceca. Alboino nel 568 mosse dalla Pannonia
verso l'Italia assieme ad altre popolazioni germaniche, nel marzo 569 occupò
Forum Iulii, l'attuale Cividale del Friuli, superò quindi ogni sbarramento
difensivo, discese dalla pianura veneta occupando Aquileia, Vicenza, Verona,
Milano, che era allora la città più romanizzata del settentrione
d'Italia e tutta la regione allora chiamata Liguria, che poi avrebbe preso
il nome di Longobardia, l'attuale Lombardia. Dalla Lombardia i Longobardi
dilagarono attraverso l' Emilia, nella Tuscia, l'attuale Toscana e giunsero
quasi fino a Roma, la superarono e occuparono Benevento. Milano doveva
la sua condizione egemonica sia alla sua posizione strategica come centro
naturale di un sistema di strade e di vie d’acqua navigabili dell’Italia
del Nord sia alla ricchezza del suo contado, che comprendeva: zone di collina
asciutta assieme a terre umide di pianura, ma soprattutto fu lo spirito
di iniziativa delle popolazioni milanesi che, trasformò un Castrum
Latino in una delle regioni più produttive d'Europa, quanto a sviluppo
agricolo, commercio ed industria. Dopo ben trè anni di assedio crollò
Pavia , che divenne la capitale sede del Re e dei parlamenti generali dei
Longobardi,
cuore dell'organismo feudale del regno italico. Già da qui nasce
l'antagonismo fra Pavia e Milano, la prima vista come la sede del potere
tirannico antireligioso il gau,
la seconda, la civitas,di
origine romana, cattolica retta da secoli da un'arcivescovo, era la più
antica sede arcivescovile del nord Italia. I Longobardi
sostituirono i Bizantini nell'organizzazione sia politica che giudiziaria
suddividendo il territorio in Ducati. Durante
i primi dieci anni di occupazione, i vari Duchi, privi del controllo di
una forte struttura monarchica, in modo autonomo e spesso in contrasto
tra loro, spogliarono i nobili romani delle loro terre e dei loro beni.
Il regno longobardo, mancava di spirito unitario e fu pertanto sempre indebolito
in modo strutturale dall'indipendentismo dei ducati
delle
regioni periferiche, convertiti da poco all'arianesimo, in parte ancora
pagani avversarono la religione cattolica. All'inizio l'economia subì
una forte recessione, poi, col passar del tempo, lo spirito romano e cristiano
ebbero il sopravvento portando alla civilizzazione dei
Longobardi
e ad una lenta conversione dall'arianesimo al cattolicesimo; fenomeno che
ebbe il suo massimo durante il regno di Agilulfo e della regina Teodolinda
(591-615) che favorirono il programma missionario di san Gregorio Magno,
battezzarono secondo il rito cattolico il figlio Adaloaldo e favorirono
la conversione dei loro sudditi. Al tempo dei Longobardi
fu compilata una descrizione dell'Italia nel monastero di Bobbio. L'Italia
risultò divisa in 15 provincie; il nostro territorio milanese era
nella Seconda provincia. L'ordinamento amministrativo dei Longobardi
fissava per Milano la sede di un duca, che stabilì
la residenza dove oggi è il luogo detto Cordusio ( la corte
del duca). Il duca
longobardo aveva il controllo diretto sulle terre circostanti fino a 20
miglia di raggio, cioè un raggio di circa 35-40 chilometri. Quindi
anche la nostra zona dipendeva dall'amministrazione longobarda di Milano.
L'Italia non fu tutta longobarda, perchè intere zone rimasero ancora
ai Bizantini: Istria, il Litorale veneto, l'Esarcato e la Pentapoli (all'incirca,
le attuali Emilia-Romagna e Marche), i ducati
di Roma, di Napoli, di Gaeta, di Amalfi e di Sorrento oltre all'odierna
Puglia e all'odierna Calabria, e le isole Corsica, Sardegna, Sicilia.
I Bizantini non rinunciarono all'idea di una riconquista. Ma ormai da soli,
con le loro sole forze, non ne erano più capaci, nonostante il carattere
militarizzato della loro amministrazione civile, oltretutto accentrata
nelle mani di un solo magistrato. Bizanzio, allora, cercò nuovi
alleati, trovandoli nel popolo dei Franchi,
eredi dei Galli (che sono gli odierni Francesi). Essi accettarono e per
tre volte scesero in Italia, guidati da Childeberto. Uno dei tanti
scontri avvenne nella nostra zona. Gregorio di Tours, lo storico dei Franchi
ed amico di Childeberto, lasciò scritto che il re giunse a Milano
e pose gli accampamenti militari fuori dalla città in luoghi campestri
di pianura; e più espliciti sono i cronisti posteriori, i quali
descrissero la battaglia avvenuta precisamente a Melegnano sulle rive del
Lambro, con lunga durata e con tanto sangue versato dall'una e dall'altra
parte. Era circa l'anno 590.
popolo nordico, guidato da re Alboino, si riversò sull'Italia nord-orientale.
I Longobardi erano una popolazione di stirpe
germanica affine per lingua, organizzazione politica, usi e costumi ai
Frisi, agli Angli ed ai Sassoni, il loro nome sembra derivi da lang
bart ossia popolo dalla lunga barba, oppure
da lang barte,
dalla lunga alabarda, vennero citati da Tacito come popolo ricco di coraggio
e valore guerriero. Insediati originariamente nel basso corso del fiume
Elba e poi migrati in Pannonia, l'odierna Ungheria occidentale e di lì
pure in Moravia, attuale repubblica Ceca. Alboino nel 568 mosse dalla Pannonia
verso l'Italia assieme ad altre popolazioni germaniche, nel marzo 569 occupò
Forum Iulii, l'attuale Cividale del Friuli, superò quindi ogni sbarramento
difensivo, discese dalla pianura veneta occupando Aquileia, Vicenza, Verona,
Milano, che era allora la città più romanizzata del settentrione
d'Italia e tutta la regione allora chiamata Liguria, che poi avrebbe preso
il nome di Longobardia, l'attuale Lombardia. Dalla Lombardia i Longobardi
dilagarono attraverso l' Emilia, nella Tuscia, l'attuale Toscana e giunsero
quasi fino a Roma, la superarono e occuparono Benevento. Milano doveva
la sua condizione egemonica sia alla sua posizione strategica come centro
naturale di un sistema di strade e di vie d’acqua navigabili dell’Italia
del Nord sia alla ricchezza del suo contado, che comprendeva: zone di collina
asciutta assieme a terre umide di pianura, ma soprattutto fu lo spirito
di iniziativa delle popolazioni milanesi che, trasformò un Castrum
Latino in una delle regioni più produttive d'Europa, quanto a sviluppo
agricolo, commercio ed industria. Dopo ben trè anni di assedio crollò
Pavia , che divenne la capitale sede del Re e dei parlamenti generali dei
Longobardi,
cuore dell'organismo feudale del regno italico. Già da qui nasce
l'antagonismo fra Pavia e Milano, la prima vista come la sede del potere
tirannico antireligioso il gau,
la seconda, la civitas,di
origine romana, cattolica retta da secoli da un'arcivescovo, era la più
antica sede arcivescovile del nord Italia. I Longobardi
sostituirono i Bizantini nell'organizzazione sia politica che giudiziaria
suddividendo il territorio in Ducati. Durante
i primi dieci anni di occupazione, i vari Duchi, privi del controllo di
una forte struttura monarchica, in modo autonomo e spesso in contrasto
tra loro, spogliarono i nobili romani delle loro terre e dei loro beni.
Il regno longobardo, mancava di spirito unitario e fu pertanto sempre indebolito
in modo strutturale dall'indipendentismo dei ducati
delle
regioni periferiche, convertiti da poco all'arianesimo, in parte ancora
pagani avversarono la religione cattolica. All'inizio l'economia subì
una forte recessione, poi, col passar del tempo, lo spirito romano e cristiano
ebbero il sopravvento portando alla civilizzazione dei
Longobardi
e ad una lenta conversione dall'arianesimo al cattolicesimo; fenomeno che
ebbe il suo massimo durante il regno di Agilulfo e della regina Teodolinda
(591-615) che favorirono il programma missionario di san Gregorio Magno,
battezzarono secondo il rito cattolico il figlio Adaloaldo e favorirono
la conversione dei loro sudditi. Al tempo dei Longobardi
fu compilata una descrizione dell'Italia nel monastero di Bobbio. L'Italia
risultò divisa in 15 provincie; il nostro territorio milanese era
nella Seconda provincia. L'ordinamento amministrativo dei Longobardi
fissava per Milano la sede di un duca, che stabilì
la residenza dove oggi è il luogo detto Cordusio ( la corte
del duca). Il duca
longobardo aveva il controllo diretto sulle terre circostanti fino a 20
miglia di raggio, cioè un raggio di circa 35-40 chilometri. Quindi
anche la nostra zona dipendeva dall'amministrazione longobarda di Milano.
L'Italia non fu tutta longobarda, perchè intere zone rimasero ancora
ai Bizantini: Istria, il Litorale veneto, l'Esarcato e la Pentapoli (all'incirca,
le attuali Emilia-Romagna e Marche), i ducati
di Roma, di Napoli, di Gaeta, di Amalfi e di Sorrento oltre all'odierna
Puglia e all'odierna Calabria, e le isole Corsica, Sardegna, Sicilia.
I Bizantini non rinunciarono all'idea di una riconquista. Ma ormai da soli,
con le loro sole forze, non ne erano più capaci, nonostante il carattere
militarizzato della loro amministrazione civile, oltretutto accentrata
nelle mani di un solo magistrato. Bizanzio, allora, cercò nuovi
alleati, trovandoli nel popolo dei Franchi,
eredi dei Galli (che sono gli odierni Francesi). Essi accettarono e per
tre volte scesero in Italia, guidati da Childeberto. Uno dei tanti
scontri avvenne nella nostra zona. Gregorio di Tours, lo storico dei Franchi
ed amico di Childeberto, lasciò scritto che il re giunse a Milano
e pose gli accampamenti militari fuori dalla città in luoghi campestri
di pianura; e più espliciti sono i cronisti posteriori, i quali
descrissero la battaglia avvenuta precisamente a Melegnano sulle rive del
Lambro, con lunga durata e con tanto sangue versato dall'una e dall'altra
parte. Era circa l'anno 590.
L'ordinamento economico longobardo: le arimannie A capo dello stato Longobardo c'era il re, da cui dipendeva l'esercito, il potere giudiziario e amministrativo. Il re demandava ai Duchi (duces - iudices) nominati a vita il potere sulle terre e sulle genti ma molte proprietà restavano direttamente sotto la corona tramite dei Gastaldi, con nomine a scadenza e non a vita. Il comune, da commune = la comunità e il patrimonio comune, inteso come comprensivo del territorio suburbano, si suddivideva in gau, cioè in chi deteneva potere a vario livello ed in civitas, cioè la classe dei vinti, ,che doveva obbedire e subire, composta dagli indigeni italiani e dai cittadini romani residui. L'economia locale era fondamentalmente basata sull'agricoltura, che da secoli immemorabili, nella nostra zona, era attivizzata e intensificata, specialmente dopo ogni catastrofe bellica o naturale: nel periodo del re longobardo Ariberto II (702-712) la nostra Bassa Milanese è segnalata per la fertilità dei campi. Attorno a Milano esisteva un tipico ordinamento longobardo per cui i signori di stirpe militare longobarda erano i proprietari, ma non lavoravano direttamente le loro terre e il loro fondo rustico: San Giuliano Milanese, la vicina Zivido, Locate Triulzi, la cascina Decima, Mediglia, nel secolo ottavo erano la residenza di uomini liberi che militavano nell'esercito longobardo e vivevano in questi luoghi: le proprietà fondiarie erano prima a regime di grande dominio, ora erano quasi accampamenti militari. Tali uomini erano chiamati Arimanni (nel latino medioevale arimanus, che deriva dal longobardo hariman, che vuol dire guerriero), ed il loro territorio era l'arimannia. Gli arimanni erano dunque, nell'ordinamento statale longobardo e poi anche in quello franco-feudale, i soldati appartenenti ad una guarnigione stabile: a loro era assegnata la terra dal loro re, a titolo di proprietà ereditaria e inalienabile, per il loro mantenimento; mentre in origine gli arimanni erano i liberi, cioè coloro che, pur essendo sudditi, godevano di speciali diritti civili e politici. L'amministrazione delle terre del sovrano e la riscossione dei redditi furono affidate ai gastaldi, speciali amministratori con attribuzioni civili, militari e giudiziarie, e con il compito di controllare i duchi. L'ordinamento sociale della popolazione longobarda si fondava sulla fara, che era un gruppo gentilizio o parentale-famigliare, con finalità anche militari, i cui membri o discendevano da un antenato comune o erano aggregati da particolari di nascita e di matrimonio. Il nome fara è rimasto in alcuni nomi di paesi o di città: Fara di Gera d'Adda; Fara Olivana; Fara Basiliana; Fara di Gallarate; Fara Novarese; Fara Sabina; Fara Vicentino; Fara San Martino. La rete degli insediamenti longobardi è riconoscibile anche da altri nomi, gaggio che è il bosco cintato e riservato, cafaggio (il nome longobardo era gahagi) che vuol dire luogo appartato per custodirvi le bestie. Il commercio attraverso la Vettabia Il re longobardo Liutprando, l'anno 715, fece alcune concessioni agli abitanti di Comacchio per il trasporto fluviale: si tratta di prestazioni che i Comacchiesi devono dare soltanto a determinati posti di dogana sulla linea di transito del Po ed i suoi affluenti Oglio, Adda e Lambro. Ed il cronista Landolfo Seniore narra che il fiume Po, collegato con il Lambro e la Vettabia, era la via per far arrivare a Milano ogni sorta di merce ultramarina. Lambro e Vettabia erano, quindi, un mezzo di trasporto quotidiano delle merci alla metropoli milanese. Il fiume Lambro è unito al Po nella località Corte Sant'Andrea, mentre la Vettabia è unita al Lambro nella zona chiamata oggi La Cappuccina. Lo stesso vocabolo Vettabia è la trasposizione italiana di un termine latino: vectabilis, che significa precisamente una condizione di trasportabilità. A Milano perciò arrivavano, mediante la navigazione sul Po, sul Lambro e sulla Vettabia, utensili, prodotti agricoli, oggetti di lusso, i manufatti artigiani, le spezie, e soprattutto il sale che evidentemente doveva essere trasportato dai paesi rivieraschi. I Franchi in Lombardia L'ultimo re dei Longobardi fu Desiderio che cercò di attuare una politica di alleanza con i Franchi. Per concretare questo scopo diede come spose 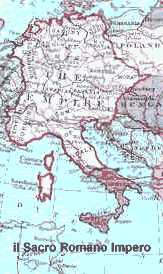 le
sue due figlie a Carlomanno e a Carlo, il futuro Carlomagno. le
sue due figlie a Carlomanno e a Carlo, il futuro Carlomagno. 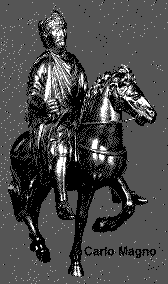 Ma
presto Carlo ripudiò la moglie e venne in Italia per combattere
Desiderio che aveva ripreso la politica di aggressione contro il papa Adriano
I. Per la valle di Susa entrò nella pianura, assediò
Pavia e fece prigioniero Desiderio, il cui figlio resistette eroicamente
ma invano a Verona. Ebbe così fine il dominio dei Longobardi
in Italia, e il loro regno passò ai Franchi:
Carlo nel 774 assumeva il titolo di re dei Franchi
e dei Longobardi. Nell'Italia settentrionale
gli Italiani continuarono ad essere sudditi. Piuttosto che aver cambiato
padrone, in realtà se ne trovarono due sulle spalle, perchè
accanto ai funzionari franchi rimasero anche
quelli longobardi. I Franchi
costruirono un regno robusto, burocratico ed organizzato. Nel Natale dell'800
Papa LeoneIII° incoronò Carlo imperatore del Sacro Romano Impero.
Carlo Magno sostituì il duca longobardo,
ed al suo posto creò il conte dal latino comes,
compagno, inteso come compagno del rè, cioè chi accompagnava
il Re in guerra e nelle funzioni di governo. Il potere politico del
conte si fuse con quello religioso nell'autorità del vescovo, rappresentante
ufficiale del re, presidente nelle assemblee dei principi, e talvolta organizzatore
delle fortificazioni della città e capo dell'amministrazione. Ma
presto Carlo ripudiò la moglie e venne in Italia per combattere
Desiderio che aveva ripreso la politica di aggressione contro il papa Adriano
I. Per la valle di Susa entrò nella pianura, assediò
Pavia e fece prigioniero Desiderio, il cui figlio resistette eroicamente
ma invano a Verona. Ebbe così fine il dominio dei Longobardi
in Italia, e il loro regno passò ai Franchi:
Carlo nel 774 assumeva il titolo di re dei Franchi
e dei Longobardi. Nell'Italia settentrionale
gli Italiani continuarono ad essere sudditi. Piuttosto che aver cambiato
padrone, in realtà se ne trovarono due sulle spalle, perchè
accanto ai funzionari franchi rimasero anche
quelli longobardi. I Franchi
costruirono un regno robusto, burocratico ed organizzato. Nel Natale dell'800
Papa LeoneIII° incoronò Carlo imperatore del Sacro Romano Impero.
Carlo Magno sostituì il duca longobardo,
ed al suo posto creò il conte dal latino comes,
compagno, inteso come compagno del rè, cioè chi accompagnava
il Re in guerra e nelle funzioni di governo. Il potere politico del
conte si fuse con quello religioso nell'autorità del vescovo, rappresentante
ufficiale del re, presidente nelle assemblee dei principi, e talvolta organizzatore
delle fortificazioni della città e capo dell'amministrazione.
Fu ampliato e maggiormente diffuso il feudalesimo, un sistema di governo politico-economico. Esso si basava sulla concessione di terre fatta dal sovrano ad un suddito (e questa operazione si chiama beneficio ed il suddito diventava feudatario), sulla prestazione e sulla fedeltà del suddito al sovrano (e ciò si chiama vassallaggio, dalla parola tedesca gewas che significa servo), e sull'esercizio di prerogative sovrane concesse al suddito feudatario (e ciò si chiama immunità). Quindi il vero rapporto politico ed economico era del tutto personale, tra superiore ed inferiore. Leggi 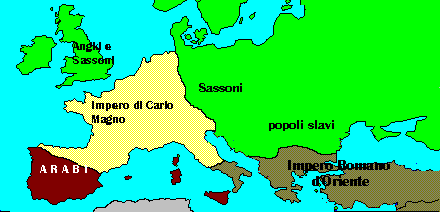 speciali,
che erano chiamate capitolari, reggevano questo sistema; e il sovrano poteva
controllare tutto mediante i suoi diretti controllori che erano chiamati
missi dominici (gli ambasciatori del sovrano padrone). Melegnano,
nei secoli VIII e IX, e incorporato nella contea franca di Milano, con
tutte le conseguenze sociali e non soltanto politiche. Con Ludovico il
Pio, figlio di Carlo Magno, il feudalesimo raggiunge il suo massimo sviluppo, speciali,
che erano chiamate capitolari, reggevano questo sistema; e il sovrano poteva
controllare tutto mediante i suoi diretti controllori che erano chiamati
missi dominici (gli ambasciatori del sovrano padrone). Melegnano,
nei secoli VIII e IX, e incorporato nella contea franca di Milano, con
tutte le conseguenze sociali e non soltanto politiche. Con Ludovico il
Pio, figlio di Carlo Magno, il feudalesimo raggiunge il suo massimo sviluppo, 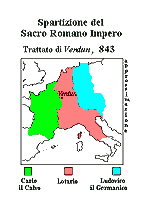 ma
anche la sua iniziale involuzione: la potenza dei feudi ormai era grande,
ed i maggiori feudi erano diventati ereditari e costituivano veri e propri
piccoli staterelli. In Italia il feudo di Milano era tra i maggiori,
ed era un feudo ecclesiastico, come lo erano quelli di Ivrea sul Piemonte
e Liguria, Friuli, Toscana, Spoleto, Ravenna, Farfa, Montecassino, Nonantola
e Cesauria. Essendo Milano un feudo ecclesiastico ne derivava che
l'arcivescovo ed i suoi subalterni erano funzionari pubblici e responsabili
per l'amministrazione: forni, mulini, giustizia, tributi, maritaggio, moneta,
guerra e pace, costruzioni di fortezze. Nell'ingranaggio feudale
vennero, quindi coinvolti anche i membri del clero, vescovi ed abati
di monasteri, e parecchi di loro furono dipendenti vassalli dello stesso
imperatore. Questa condizione di sudditanza dall'imperatore, pur
essendo ecclesiastici, poteva servire anche per afferrare o per meglio
consolidare le maggiori cariche e dignità cittadine, non soltanto
per se stessi ma anche per i familiari e per gli amici. L'arcivescovo di
Milano fu legato all'imperatore anche dopo il dissolvimento carolingio
dell'anno 887, e mantenne una continuità di tradizione riconosciuta
dall'imperatore Ottone I di Sassonia, nuovo sovrano anche dell'Italia. ma
anche la sua iniziale involuzione: la potenza dei feudi ormai era grande,
ed i maggiori feudi erano diventati ereditari e costituivano veri e propri
piccoli staterelli. In Italia il feudo di Milano era tra i maggiori,
ed era un feudo ecclesiastico, come lo erano quelli di Ivrea sul Piemonte
e Liguria, Friuli, Toscana, Spoleto, Ravenna, Farfa, Montecassino, Nonantola
e Cesauria. Essendo Milano un feudo ecclesiastico ne derivava che
l'arcivescovo ed i suoi subalterni erano funzionari pubblici e responsabili
per l'amministrazione: forni, mulini, giustizia, tributi, maritaggio, moneta,
guerra e pace, costruzioni di fortezze. Nell'ingranaggio feudale
vennero, quindi coinvolti anche i membri del clero, vescovi ed abati
di monasteri, e parecchi di loro furono dipendenti vassalli dello stesso
imperatore. Questa condizione di sudditanza dall'imperatore, pur
essendo ecclesiastici, poteva servire anche per afferrare o per meglio
consolidare le maggiori cariche e dignità cittadine, non soltanto
per se stessi ma anche per i familiari e per gli amici. L'arcivescovo di
Milano fu legato all'imperatore anche dopo il dissolvimento carolingio
dell'anno 887, e mantenne una continuità di tradizione riconosciuta
dall'imperatore Ottone I di Sassonia, nuovo sovrano anche dell'Italia. |
|
tel.02 9837517 Melegnano Via Castellini, 27 |