

Associazioni
 |
melegnano.net |  |
Melegnano.net
Associazioni |
|
|
| Censimento
del 1722
Il riordinamento ad ala perequazione dei tributi hanno costituito uno dei principali intenti della politica riformistica attuata dall'Austria nello stato di Milano; ne fu innovazione, senz'altro la più feconda del secolo XVIII, la imposizione fondiaria in base ad un catasto dei fabbricati e dei terreni con relativi redditi. Gli studi preliminari per la rilevazione mappale di tutto il territorio si iniziano nel 1718 e la complessa operazione viene effettuata e condotta a termine fra gli anni 1720 e 1723; si giunge pertanto ad un preciso rilievo grafico del nostro borgo e di tutti i poderi che gli stanno d'attorno, al quale si accompagna una inchiesta dettagliata in loco, sotto la guida di una specie di questionario preordinato; 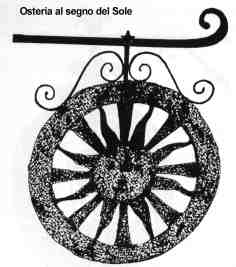 possedere tutta questa importante documentazione significa avere degli
elementi precisi e circostanziati per ricostruire un aspetto della storia
di Melegnano in quel periodo. Naturalmente il nuovo ordine aveva
fatto scattare in tutto il ducato una tempesta di ricorsi; nella tattica
dilatoria, i contribuenti vedevano il più potente alleato contro
la politica delle riforme; ma giunti all'anno 1733, la guerra di successione
polacca induceva nei Milanese, lentamente adattatosi alla dominazione austriaca,
dei nuovi sconvolgimenti. L'enorme lavoro già compiuto per la formazione
dei catasti venne interrotto, ed il materiale relativo accantonato negli
archivi di Mantova, da cui doveva essere tratto con miglior fortuna solo
dopo due decenni. Esistono molte notizie riguardanti terreni e fabbricati,
che scaturiscono da quella basilare documentazione che sono i catasti,
ma ci soffermeremo solo su di un punto molto singolare: gli Osti e le Osterie
esistenti in Melegnano nell'anno 1722 alla data delle rilevazioni per il
catasto cosiddetto di Maria Teresa, ma che in effetti si fecero sotto il
regno del di lei padre, l'imperatore Carlo VI. Giova precisare che nessuna
altra osteria o bettolino o locanda c'era in quel tempo al di fuori di
quelle che noi andiamo elencando; ciò significa che le altre che
compaiono qua e là nella storia di Melegnano, o erano scomparse,
o venute dopo l'anno 1722, o avevano mutato nome.
possedere tutta questa importante documentazione significa avere degli
elementi precisi e circostanziati per ricostruire un aspetto della storia
di Melegnano in quel periodo. Naturalmente il nuovo ordine aveva
fatto scattare in tutto il ducato una tempesta di ricorsi; nella tattica
dilatoria, i contribuenti vedevano il più potente alleato contro
la politica delle riforme; ma giunti all'anno 1733, la guerra di successione
polacca induceva nei Milanese, lentamente adattatosi alla dominazione austriaca,
dei nuovi sconvolgimenti. L'enorme lavoro già compiuto per la formazione
dei catasti venne interrotto, ed il materiale relativo accantonato negli
archivi di Mantova, da cui doveva essere tratto con miglior fortuna solo
dopo due decenni. Esistono molte notizie riguardanti terreni e fabbricati,
che scaturiscono da quella basilare documentazione che sono i catasti,
ma ci soffermeremo solo su di un punto molto singolare: gli Osti e le Osterie
esistenti in Melegnano nell'anno 1722 alla data delle rilevazioni per il
catasto cosiddetto di Maria Teresa, ma che in effetti si fecero sotto il
regno del di lei padre, l'imperatore Carlo VI. Giova precisare che nessuna
altra osteria o bettolino o locanda c'era in quel tempo al di fuori di
quelle che noi andiamo elencando; ciò significa che le altre che
compaiono qua e là nella storia di Melegnano, o erano scomparse,
o venute dopo l'anno 1722, o avevano mutato nome.  Prendendo
come punto di partenza i dati catastali del primo quarto di quel secolo,
la configurazione della comunità di Melegnano non sarà di
molto cambiata per tutto il Settecento ed oltre. Alla luce dei documenti
risulta che, raccolti i rilievi mappali il giorno 29 di ottobre di quell'anno
sedeva in sala del castello mediceo il magnifico signore di Novara conte
Ottaviano Tornielli Commissario Cesareo, assistito dal cancelliere Paolo
Schiavi; il console della comunità di Melegnano era assente, e lo
sostituiva Prendendo
come punto di partenza i dati catastali del primo quarto di quel secolo,
la configurazione della comunità di Melegnano non sarà di
molto cambiata per tutto il Settecento ed oltre. Alla luce dei documenti
risulta che, raccolti i rilievi mappali il giorno 29 di ottobre di quell'anno
sedeva in sala del castello mediceo il magnifico signore di Novara conte
Ottaviano Tornielli Commissario Cesareo, assistito dal cancelliere Paolo
Schiavi; il console della comunità di Melegnano era assente, e lo
sostituiva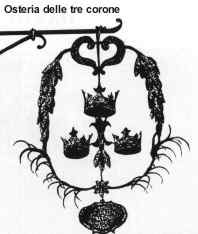 il
sindaco anziano, col Ragionato, ovverosia segretario, Francesco Spernazzati.
«Interrogato come si chiami di che età ove habita e qual sii
la sua professione, risponde: Io sono Carlo Giuseppe Coldano quondam Giovanni
Antonio d'anni 49 habito in Melegnano ove faccio da Sindaco et il mio esercitio
si è da taverniere al segno delle
Due Spade ». Si può ritenere,
dal cognome di questo oste che la sua famiglia fosse la stessa di quel
canonico della Collegiata, (prima aveva una cappellania a Vizzolo), che
ha lasciato il noto prezioso manoscritto sulla antica storia del nostro
borgo; inoltre si viene a sapere che l'oste delle
Due Spade pagava al Marchese di Marignano
lire 1.800 annue per il dazio del vino (<datio vecchio del Bollino>),
nella quale somma era compresa la sublocazione del dazio stesso a tutte
le altre osterie, le quali assommavano al numero di tredici. <Oltre
la rendita dè terreni vi sono tredici Osterie compresi li Bettolini,
cioè quella che esercisco io al
segno delle Due Spade, altra
al
segno del Cappello, altra al
segno delli Tre Re, altra al
segno di San Giacomo, altra al
segno del Angiolo, altra al
segno della Croce Bianca, altra al
segno del Sole, altra al
segno della Cernia, altra al
segno della Fontana, altra al
segno del Leone, altra al
segno del Gallo, et altraal
segno di San Giorgio ». il
sindaco anziano, col Ragionato, ovverosia segretario, Francesco Spernazzati.
«Interrogato come si chiami di che età ove habita e qual sii
la sua professione, risponde: Io sono Carlo Giuseppe Coldano quondam Giovanni
Antonio d'anni 49 habito in Melegnano ove faccio da Sindaco et il mio esercitio
si è da taverniere al segno delle
Due Spade ». Si può ritenere,
dal cognome di questo oste che la sua famiglia fosse la stessa di quel
canonico della Collegiata, (prima aveva una cappellania a Vizzolo), che
ha lasciato il noto prezioso manoscritto sulla antica storia del nostro
borgo; inoltre si viene a sapere che l'oste delle
Due Spade pagava al Marchese di Marignano
lire 1.800 annue per il dazio del vino (<datio vecchio del Bollino>),
nella quale somma era compresa la sublocazione del dazio stesso a tutte
le altre osterie, le quali assommavano al numero di tredici. <Oltre
la rendita dè terreni vi sono tredici Osterie compresi li Bettolini,
cioè quella che esercisco io al
segno delle Due Spade, altra
al
segno del Cappello, altra al
segno delli Tre Re, altra al
segno di San Giacomo, altra al
segno del Angiolo, altra al
segno della Croce Bianca, altra al
segno del Sole, altra al
segno della Cernia, altra al
segno della Fontana, altra al
segno del Leone, altra al
segno del Gallo, et altraal
segno di San Giorgio ».  A
parte il dazio vecchio che tutti gli osti pagavano nelle mani del Coldani,
c'era anche un dazio nuovo, riscosso da un tale Carlo Rancati, appaltatore
per conto delle sorelle De Mena Pasquali, il cui padre, anni addietro,
l'aveva acquistato dalla Regia Camera. La casa in cui si gestisce l'osteria
al
segno delle Due Spade è di proprietà
dei marchesi Rovida; di essa si sente spesso parlare nella storia melegnanese;
deve essere comunque stata una delle più importanti se venne scelta
per quartier generale dal generale Massena nelle giornate di maggio del
1796. L'oste che viene convocato dopo il Coldani è Giovan
Battista Farina, il quale conduce la ormai ben nota locanda
di San Giorgio, forse tra le più
antiche; la casa in cui si esercita l'osteria è dei minori Cornegliani.
Racconta lo storico Coldani che fu proprio lì che, il 31 gennaio
1706, si tenne un gran consiglio di guerra intorno al principe di Vaudemont;
vi parteciparono il duca di Vendòme, comandante in capo delle truppe
gallo-ispane, che nell'agosto precedente aveva sconfitto gli imperiali
a Cassano; inoltre l'abate Giulio Alberoni di Piacenza, che doveva poi
diventare cardinale e grande diplomatico; il generale francese de la Feuillade
che si era reso padrone della Savoia e di Susa... La locanda
di San Giorgio si riteneva il covo dei
contrabbandieri; le merci provenienti dal Lodigiano erano sottoposte a
certi dazi allorché si presentavano al passaggio del ponte; ecco
perché talora venivano sequestrate, depositate al San Giorgio, eppoi
magari introdotte di sfroso, colla connivenza dei gabellieri. A
parte il dazio vecchio che tutti gli osti pagavano nelle mani del Coldani,
c'era anche un dazio nuovo, riscosso da un tale Carlo Rancati, appaltatore
per conto delle sorelle De Mena Pasquali, il cui padre, anni addietro,
l'aveva acquistato dalla Regia Camera. La casa in cui si gestisce l'osteria
al
segno delle Due Spade è di proprietà
dei marchesi Rovida; di essa si sente spesso parlare nella storia melegnanese;
deve essere comunque stata una delle più importanti se venne scelta
per quartier generale dal generale Massena nelle giornate di maggio del
1796. L'oste che viene convocato dopo il Coldani è Giovan
Battista Farina, il quale conduce la ormai ben nota locanda
di San Giorgio, forse tra le più
antiche; la casa in cui si esercita l'osteria è dei minori Cornegliani.
Racconta lo storico Coldani che fu proprio lì che, il 31 gennaio
1706, si tenne un gran consiglio di guerra intorno al principe di Vaudemont;
vi parteciparono il duca di Vendòme, comandante in capo delle truppe
gallo-ispane, che nell'agosto precedente aveva sconfitto gli imperiali
a Cassano; inoltre l'abate Giulio Alberoni di Piacenza, che doveva poi
diventare cardinale e grande diplomatico; il generale francese de la Feuillade
che si era reso padrone della Savoia e di Susa... La locanda
di San Giorgio si riteneva il covo dei
contrabbandieri; le merci provenienti dal Lodigiano erano sottoposte a
certi dazi allorché si presentavano al passaggio del ponte; ecco
perché talora venivano sequestrate, depositate al San Giorgio, eppoi
magari introdotte di sfroso, colla connivenza dei gabellieri.  Appena
a valle del ponte, sulla riva destra c'era il cosiddetto porto, ed il Lambro
si passava nascostamente, per gli scopi suddetti, con le barche. L'oste
Giovanni Battista Farina al segno di San
Giorgio, non era altri che il figlio di
quel tal Santo Farina che conduceva l'osteria della Senavra, alle porte
di Milano, lungo la strada del Naviletto; il palazzo che fu la residenza
campestre di Don Ferrante Gonzaga governatore di Milano, dopo vari passaggi
di proprietà era finito nelle mani del marchese Ferdinando Rovida,
Questore Ordinario, il quale lo abbellì, ma non riuscì a
farne di meglio che mettervi dei pigionanti ed una « hosteria con
beccheria». Carlo Maria Maggi, ne Il Barone di Birbanza, celebra
fra gli altri paradisi di leccornie che si gustavano alla periferia della
città i stracchin de la Senavra, che il nostro buon Farina, prima
di finire a Melegnano, si assicurava dai fittabili e bergamini i quali
li producevano nei loro casoni delle cascine circostanti. Dai dati
complessivi rilevati per la compilazione del catasto rurale ed urbano si
ricava che il perticato della comunità di Melegnano assommava a
pertiche 5.962 e 25 tavole, che le osterie erano per metà del Magistrato
e per metà del Marchese Medici; sempre del Marchese Feudatario la
«pescaggione» nel fiume Lambro, del Magistrato il cosiddetto
porto e del Marchese Brivio l'unico Mulino, ossia quello della Valle. Il
marchese Cesare Brivio era proprietario della casa dove si gestiva l'osteria
al
segno del Cappello, condotta da un tale
Giuseppe Nava; questa avrebbe dovuto essere con tutta probabilità
la
locanda del «Cappello rosso»
già esistente nel Cinquecento, dove gli intendenti dell'armata di
Francesco I° avevano predisposto l'alloggio del sovrano; egli non volle
fermarsi nel borgo ma pose il suo quartiere fra Casalmaiocco, Dresano e
Mulazzano. L'Osteria del Cappello
si trovava dalle parti del Ponte di Milano, come quella dei Tre Re;
l'oste Cesare Brambilla pagava l'affitto alle monache di Santa Caterina.
I «Tre Re» Appena
a valle del ponte, sulla riva destra c'era il cosiddetto porto, ed il Lambro
si passava nascostamente, per gli scopi suddetti, con le barche. L'oste
Giovanni Battista Farina al segno di San
Giorgio, non era altri che il figlio di
quel tal Santo Farina che conduceva l'osteria della Senavra, alle porte
di Milano, lungo la strada del Naviletto; il palazzo che fu la residenza
campestre di Don Ferrante Gonzaga governatore di Milano, dopo vari passaggi
di proprietà era finito nelle mani del marchese Ferdinando Rovida,
Questore Ordinario, il quale lo abbellì, ma non riuscì a
farne di meglio che mettervi dei pigionanti ed una « hosteria con
beccheria». Carlo Maria Maggi, ne Il Barone di Birbanza, celebra
fra gli altri paradisi di leccornie che si gustavano alla periferia della
città i stracchin de la Senavra, che il nostro buon Farina, prima
di finire a Melegnano, si assicurava dai fittabili e bergamini i quali
li producevano nei loro casoni delle cascine circostanti. Dai dati
complessivi rilevati per la compilazione del catasto rurale ed urbano si
ricava che il perticato della comunità di Melegnano assommava a
pertiche 5.962 e 25 tavole, che le osterie erano per metà del Magistrato
e per metà del Marchese Medici; sempre del Marchese Feudatario la
«pescaggione» nel fiume Lambro, del Magistrato il cosiddetto
porto e del Marchese Brivio l'unico Mulino, ossia quello della Valle. Il
marchese Cesare Brivio era proprietario della casa dove si gestiva l'osteria
al
segno del Cappello, condotta da un tale
Giuseppe Nava; questa avrebbe dovuto essere con tutta probabilità
la
locanda del «Cappello rosso»
già esistente nel Cinquecento, dove gli intendenti dell'armata di
Francesco I° avevano predisposto l'alloggio del sovrano; egli non volle
fermarsi nel borgo ma pose il suo quartiere fra Casalmaiocco, Dresano e
Mulazzano. L'Osteria del Cappello
si trovava dalle parti del Ponte di Milano, come quella dei Tre Re;
l'oste Cesare Brambilla pagava l'affitto alle monache di Santa Caterina.
I «Tre Re»  erano
i Re Magi; le loro urne, conservate in Sant'Eustorgio, erano emigrate verso
la Germania, epperciò venivano considerati patroni dei viaggiatori.
Di qui il titolo dato agli alberghi di molte città d'Europa; non
ultimo alla antica locanda di Melegnano, esistente ancora ai tempi del
Coldani come l'albergo del Cappello: e di men pregiata mostra e ragione
del signor Angelo Codeleoncini che l'ebbe a costruzione dalla famiglia
Brasca; quello sontuoso dei Tre Re, che si chiuse all'epoca di mia prima
gioventù era nella prima casa messa a civil Costume e posseduta
dalla famiglia Gallina ». Si può dire che la metà
delle case in cui erano gestite le osterie apparteneva ai conventi di Melegnano,
od alla chiesa o suoi preti; così l'osteria al segno del Leone apparteneva
ai frati Serviti; quella dell'Agnello al convento del Carmine; quella della
Fontana al monastero milanese di Santa Marcellina; quella di San Giacomo
al capitolo della nostra Collegiata di San Giovanni Battista, e quella
del Gallo al prete Innocente Farina. Dell'osteria
del Sole fa cenno anche il Saresani: e nel
mezzo, di prospettiva al castello e fiancheggiata d'altre case e botteghe
l'osteria
del Sole, che anticamente serviva per scuderia
ducale ». All'epoca del nostro censimento l'oste si chiamava Francesco
Craispergher, cognome che troviamo anche in un elenco di macellai e salumieri;
il capostipite era un funzionario austriaco, forse militare, che allignò
ben bene nel nostro borgo dandosi al commercio; non è detto che
ancora oggi non vi sia in Melegnano qualche suo discendente con cognome
magari italianizzato. Non erano forse austriaci anche i Friss, che poi
si trasformarono in Frisi? Pure gli Spagnoli ci lasciarono in eredità
dei rappresentanti dell'esercito, come quel capitano Pereira, il quale
possedeva una vigna con case nella attuale via Predabissi, case nelle quali
aveva sede l'osteria della Croce Bianca,
gestita da un certo Giuseppe Monti quondam Giovanni Battista. Ma l’elenco
non è ancora finito;
l'osteria della
Cernia era condotta da un certo Giovanni Moroni
di sessant'anni, il quale era anche proprietario della casa in cui si trovava;
eppoi c'era l'osteria dell'Angelo,
« a tempi antichi dé Rossi di Parma, in seguito di casa Magnetti...
», scrive il Saresani, gestita dall'oste Innocente Robioni. La precisa
nota da cui sono state tratte queste brevi notizie non consente di individuare
l'ubicazione di tutte le osterie o locande in esso nominate; per la gran
parte però i vecchi Melegnanesi hanno qualche ricordo personale
o un « sentito dire », per cui questo importante aspetto della
vita locale d'altri tempi viene documentato; altri potrà man mano
approfondirlo e ne deriverà sempre maggior interesse alla storia
del borgo: per le locande di Melegnano è passata più che
non si creda, anche un Po’ di storia di Milano. erano
i Re Magi; le loro urne, conservate in Sant'Eustorgio, erano emigrate verso
la Germania, epperciò venivano considerati patroni dei viaggiatori.
Di qui il titolo dato agli alberghi di molte città d'Europa; non
ultimo alla antica locanda di Melegnano, esistente ancora ai tempi del
Coldani come l'albergo del Cappello: e di men pregiata mostra e ragione
del signor Angelo Codeleoncini che l'ebbe a costruzione dalla famiglia
Brasca; quello sontuoso dei Tre Re, che si chiuse all'epoca di mia prima
gioventù era nella prima casa messa a civil Costume e posseduta
dalla famiglia Gallina ». Si può dire che la metà
delle case in cui erano gestite le osterie apparteneva ai conventi di Melegnano,
od alla chiesa o suoi preti; così l'osteria al segno del Leone apparteneva
ai frati Serviti; quella dell'Agnello al convento del Carmine; quella della
Fontana al monastero milanese di Santa Marcellina; quella di San Giacomo
al capitolo della nostra Collegiata di San Giovanni Battista, e quella
del Gallo al prete Innocente Farina. Dell'osteria
del Sole fa cenno anche il Saresani: e nel
mezzo, di prospettiva al castello e fiancheggiata d'altre case e botteghe
l'osteria
del Sole, che anticamente serviva per scuderia
ducale ». All'epoca del nostro censimento l'oste si chiamava Francesco
Craispergher, cognome che troviamo anche in un elenco di macellai e salumieri;
il capostipite era un funzionario austriaco, forse militare, che allignò
ben bene nel nostro borgo dandosi al commercio; non è detto che
ancora oggi non vi sia in Melegnano qualche suo discendente con cognome
magari italianizzato. Non erano forse austriaci anche i Friss, che poi
si trasformarono in Frisi? Pure gli Spagnoli ci lasciarono in eredità
dei rappresentanti dell'esercito, come quel capitano Pereira, il quale
possedeva una vigna con case nella attuale via Predabissi, case nelle quali
aveva sede l'osteria della Croce Bianca,
gestita da un certo Giuseppe Monti quondam Giovanni Battista. Ma l’elenco
non è ancora finito;
l'osteria della
Cernia era condotta da un certo Giovanni Moroni
di sessant'anni, il quale era anche proprietario della casa in cui si trovava;
eppoi c'era l'osteria dell'Angelo,
« a tempi antichi dé Rossi di Parma, in seguito di casa Magnetti...
», scrive il Saresani, gestita dall'oste Innocente Robioni. La precisa
nota da cui sono state tratte queste brevi notizie non consente di individuare
l'ubicazione di tutte le osterie o locande in esso nominate; per la gran
parte però i vecchi Melegnanesi hanno qualche ricordo personale
o un « sentito dire », per cui questo importante aspetto della
vita locale d'altri tempi viene documentato; altri potrà man mano
approfondirlo e ne deriverà sempre maggior interesse alla storia
del borgo: per le locande di Melegnano è passata più che
non si creda, anche un Po’ di storia di Milano.
Aspetti delle locande ed osterie di Melegnano e contado Si va col pensiero a tante della stessa epoca, descritte nei diari o ricordate nella letteratura. Più ancora ci sono impresse nella mente certe stampe con vignette e legende scherzose. C'è chi arriva alla locanda col proprio carretto od a cavallo da paesi vicini, per fare i suoi affari in borgo, specie nei giorni di mercato o di fiera, rientrando alla fine a casa propria; ma c'era anche qualche viaggiatore che veniva di più lontano con cavalcatura, chiedendo di cena, e alloggio e stallo. Eppoi la mattina dopo si ripeteva la scena di quel quadretto comune a tutte le osterie: "Oste, facciamo il conto! Un mezzo di vino, un asse di pane e due di companatico. - Va bene. - Otto assi per la ragazza... – Anche questo sta bene. - E infine, due assi per il fieno del mulo. - Oh mio Dio, questo mulo mi manda in rovina...!" Qualcuno si ricorda ancora di quando sussisteva ancora un'osteria di paese, con tutti i suoi arredi, oggetti ed aggeggi, come un secolo prima e forse più addietro; comunque nello stesso posto, come scritto nell'inventario di un atto notarile: « sembra di vedere ancora quel lunghissimo tavolo di noce di molti anni fa; il ciocco di legno scoppietta ancora sotto la grande cappa di camino ». Il rame da cucina ricopriva tutte le pareti; lucerne ad olio e candelieri con fumose candele di sego spandevano insieme alla loro flebile luce un acre odore; nella parete di contro imperava la "zainera”, ovverosia quella specie di scaffale ad archetti e colonnine, con disposti sui ripiani le “zaine” ed i boccali, mentre le tazze con manico erano appese in bella fila nel giro più alto ». Una zaina di vino corrispondeva al “quartin"; ci volevano, come è evidente, due quartini per fare "el mezz", e con due mezzi si faceva il boccale. Poi, per intenderci, in allegra brigata, si chiedeva "ona pinta", ("ona bela pintazza!"), che era fatta di due boccali ed equivaleva al fiasco. Ma il vino si beveva, come si beve, per accompagnare il mangiare; ovvero si mangiava anche, (magari anche a forza di spuntini), per accompagnare il vino. Perciò alla catena del camino era sempre attaccato un pentolone, in cui bollivano a gran fuoco carne di ogni qualità e salami ». In più, Melegnano era fermata obbligata delle diligenze e della posta a cavalli; quindi un grande traffico di vetture cariche di viaggiatori provenienti dalle parti più svariate d'Italia e d'Europa, i quali alle nostre locande chiedevano di rifocillarsi, alloggiare e farsi passare certi spaventi occorsi lungo le nostre avventurose strade. |
|
tel. 02 9837517 Melegnano Via Castellini, 27 |